

Domani sarà ufficialmente celebrato il Primo Maggio, la festa dei lavoratori. Rivedo con gli occhi della memoria gli anarchici, i socialisti, i comunisti, i repubblicani del paese, complessivamente definiti sovversivi, che, nonostante il rischio di finire in galera, trovavano il modo di ricordarci la ricorrenza. Franci Mammoliti inalberava spavaldamente un garofano rosso all’occhiello della sua vecchia ma linda (la moglie ci teneva) giacchetta di telaccia bruna.
Certo, non affrontava la piazza, il corso. Girava per le vineie, come tutti gli altri giorni, a offrire il pesce a chi aveva le poche lire per acquistarlo. Il garofano informava anche noi ragazzini – di solito destinatari di qualche vaga nozione paterna, materna, avita - circa la data. Era proprio lo scopo dell’inconsueto ornamento. Ma Franci ci insegnava parecchio di più. L’uomo, l’uomo vero, non si arrende, non si piega, non rinnega la sua fede; combatte per la libertà, per la giustizia, perché gli altri possano ascoltare la sua verità.
Ciccio Latorre era più cauto. Ogni momento tirava fuori un fazzoletto, che tutto sommato poteva apparire rosso, come se avesse il raffreddore. Tobiolo non esibiva colori. Abbandonata la forgia e armato di una sgangherata bicicletta dall’infinito portabagagli, girava il paese a farsi fare le condoglianze dagli amici e a litigare con gli avversari. La sua voce roca, quasi in falsetto, avvertiva il passante cento metri distante che la palingenesi costituiva un’urgente necessità popolare. I sovversivi più prudenti, quelli che avevano le 5 lire occorrenti per lo schiticchio, se n’andavano in campana, come fosse Pasquetta. Ma quel giorno era come fosse in vigore una tregua d’armi.
Neppure i fascisti più indomiti protestavano. Il maresciallo Belsito faceva finta – e lo diceva in un orecchio a qualcuno - di non vedere l’assembramento che si era formato davanti alla bottega di Ciccio Surace, e faceva finta di non sentire Ciccio Falletti che concionava nel bel mezzo di Piazza Portosalvo, e prometteva un’imminente rivoluzione mondiale.
Il Primo Maggio 1944, salammo la scuola. Facemmo nostra la festa. Bebè Rodinò, figlio antifascista di un antifascista, s’inerpicò sulla base del monumento ai caduti, di fronte al liceo. Aveva l’eloquio facile, la voce calda, l’intonazione giusta, il pubblico era pronto. Ce lo caricammo sulle spalle e lo portammo in trionfo. L’anno dopo, liberata la Toscopadana, il Primo Maggio divenne una festività tollerata.
Ricordo il mio primo comizio, il 1 maggio del 1946. I foglietti di carta che mi tremavano in mano e la mangiata di capretto al forno che venne dopo l’iniziazione. Ricordi… lacrime di nostalgia…
A chiàgnere ‘o muòrto, so’ llàcreme pèrse. Non sapevamo niente del mondo, capivamo tuttavia che stavamo scegliendo tra rivoluzione e riformismo. Le manette intorno ai polsi di Pasquale Cavallaro, il ripudio di Togliatti della Repubblica Rossa di Caulonia erano quanto bastava per informarci che le parole potevano gonfiarsi come la schiuma in un bicchiere di birra, ma non per questo la birra sarebbe cresciuta nel bicchiere. Mico Congiusta trionfava. La via giusta stava nel mezzo, era il gradualismo turatiano; un concetto che quindici anni dopo venne replicato con quella chimera a cui fu dato il nome di “riforme di struttura”.
Il riformismo è il risvolto socialista in un paese industriale, a capitalismo evoluto. Nel nostro sudico paese era (ed è) solo una pietosa toppa. La restaurazione resistenziale dell’ideologia nordista - ampiamente anticipata dalla fascistica “battaglia del grano” e dal conseguente ilotismo contadino, con miseria annessa, a favore di Milano, Genova e Torino – stava svellendo persino quel poco d’industria e di modernizzazioni che erano spuntate nelle fessure della colonizzazione unitaria. Il capitalismo stava di casa lì, nella Padana; lontano, inafferrabile, impraticabile qui. E con esso il lavoro, la vitalità del movimento operaio. Non ci voleva la zingara per farcelo capire. Ma ce lo spiegarono anche.
Il Natale del 1947 lo trascorremmo, infatti, a Bari, tra prediche dal pulpito e folclore contadino in scena. Ci fu chiarito, senza poi tanti giri di parole, che “o ti mangi la minestra, o ti butti dalla finestra”. Non c’erano alternative. La terra era lì, i baroni pure, la terra a chi la lavora era un’antica rivendicazione del popolo. Fate un po’ di casino, intanto raccogliete qualche voto, ma non disturbate il manovratore. Poi si vedrà…E’ un impegno d’onore…
Sono passati sessant’anni, il mondo è infinitamente cambiato. Abbiamo il pane e anche la libertà. Ma né l’uno né l’altra sono opera nostra. Sono il frutto del processo tecnologico, il quale processo, in mancanza di consumatori, non potrebbe innalzare i capitalisti al rango di faraoni e consegnare ai loro attaché la mitra di sacerdoti. Per altro l’ethos del garofano rosso ha abbandonato queste sponde, pare, per sempre, e quando urli, se non sei a Piazza Cordusio nessuno ti sente.
Il garofano rosso di Franci Mammoliti è cosa del passato, una nostalgia .Oggi gli uomini veri, i veri politici, trattano, accettano il compromesso. La libertà siede in parlamento. Magari amoreggia con Bruno Vespa e con Lucia Annunziata. Ma se proprio volete aprire la Bibbia della rivoluzione, rivolgetevi a Enzo Biagi. Le idee politiche debbono calare in perfetto equilibrio, come i due totali della partita doppia. La rivoluzione scorre fra gli acuminati editoriali di Eugenio Scalfari, vittima innocente dell’astuto Berlusconi.
La patria sta a Cuneo, ed è celebrata, con le contumelie del caso contro i mafiosisti e i camorristi, dal gladiatore resistenziale Giorgio Bocca. La storia ce la spiega Paolo Mieli, da via Solferino, sull’immancabile sfondo dell’Enciclopedia voluta e diretta da Giovanni Gentile, immondamente siciliano, e per questo detta nobilmente Treccani, in puro milanese. E dove Mieli si esime, c’è sempre il rabbino di Roma a riempire il buco.
Sessant’anni di storia ci hanno spiegato – persino con grande ritardo – che i lavoratori non sono tutti egualmente oppressi. Stalin aveva perfettamente ragione quando si opponeva agli internazionalisti e propugnava l’ipotesi del socialismo in un solo paese. In verità, prima di lui l’aveva detto nel 1921 chi stava peggio: Ho Chi Min, ancora studente, a un congresso dei nobili socialisti e colonialisti francesi: i socialisti non sono dovunque socialisti. Il Primo Maggio di Parigi e il Primo Maggio di Hanoi, il Primo Maggio di Berlino e il Primo Maggio di Pretoria, il Primo Maggio di Locri e il Primo Maggio di Sesto San Giovanni non sono la stessa cosa, chiunque impartisca la benedizione dal podio.
Quando parlo di socialismo non mi riferisco alle organizzazioni politiche oggi esistenti in Europa. Le loro idee raffinate sono fuori la portata delle mie antiquate connessioni cerebrali. Ma neppure mi riferisco all’anarchismo di Franci Mammoliti. Tra il suo garofano rosso e le bandire rosse che sventoleranno domani sulle piazze di una gran parte della terra, c’è di mezzo la “grande trasformazione” del mondo.
Io non so se il socialismo sarà mai un sistema planetario, un assetto globale. E non so – se mai ci sarà – quali ne saranno la forma e i contenuti. Il mio discorso si ferma alla via per arrivarci. Essa esclude preventivamente quei precetti risultati falsi alla prova dei fatti, come l’amicizia fra i popoli e la solidarietà classista. L’esperienza storica insegna che si tratta di scempiaggini pericolose, se non di disonesti artifici per irretire i deboli, allo stesso modo del liberismo commerciale.
Caduto il comunismo, il disastro delle nazionalità russe unite con le armi dagli zar sotto il loro scettro, e in appresso apparentemente rinsaldate con fondazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), è sotto gli occhi di tutti. Sessant’anni fa nessuno dubitava che lo Stato Israele sarebbe divenuto un modello di socialismo e di convivenza civile tra popolazioni ed etnie diverse.
Come sia finita è lo vediamo a ogni ora di ogni giorno. La spartizione dell’impero britannico, in India, è costata una guerra civile e internazionale tra morti di fame indù e morti di fame maomettani, con milioni e milioni di vittime.
Non sono soltanto i contrapposti interessi economici a dividere i popoli, ma lo stadio delle rispettive strutture produttive e i rapporti giuridici e sociali che la loro diversa storia ha codificato. Ad appesantire le diversità storiche contribuisce enormemente la presenza e l’enorme influenza economica di un paese di nuovo popolamento, gli Stati Uniti d’America, il quale non è angariato nei rapporti interni e internazionali dai sedimenti di una sua vita millenaria, come i paesi d’Asia, d’Europa e d’Africa - il Vecchio Mondo.
La vastità del mercato nordamericano spinge i capitalisti europei a pretendere un mercato con lo stesso spazio. E ciò comporta la vittoria e il sopruso da parte delle regioni più forti e la sudditanza delle regioni meno forti, associate all’impero secondo il modello romano di alleanza/sudditanza e comporta anche una cosa che non si vede a occhio nudo, ma che non per questo è meno vera di un virus infettivo: i cittadini delle regioni deboli degradati a funzione del Pil delle regioni forti.
Anche il processo socialista comporta il governo mondiale dell’economia. Ma la sfida di oggi, di domani, di dopodomani sta nell’alternativa tra un accordo internazionale tra imperi continentali al servizio del grande capitale globale, ovvero la dissoluzione dei grandi Stati a favore di formazioni di piccoli (o minori) Stati, tipo principati autonomi, signorie rinascimentali, repubbliche marinare (quelle minori), le Città anseatiche; l’insieme coordinato al centro dalla programmazione economica mondiale.
Lo Stato italiano non è l’unica testimonianza del sostanziale fallimento degli Stati nazionali. Il Regno Unito, la Francia, il Belgio, l’Olanda, la Spagna, solo per citare i casi più noti, soffrono di crisi nazionali endemiche, secolari. Cechi e Slovacchi si sono saggiamente divisi, con minore saggezza lo hanno fatto le ex nazionalità sovietiche, lo dovranno fare prima o poi la Spagna e la Francia. Lo Stato regionale è una remora alla crescita delle grandi aziende capitalistiche, contiene il militarismo, realizza forme di democrazia meno indirette e una migliore coesione del pubblico interesse, nonché servizi pubblici meno distaccati dalla gente.
Lo Stato storico, il falso Stato nazionale, le Comunità continentali sono i peggiori nemici della piena occupazione. Il primo postulato del socialismo meridionale sono l’indipendenza del paese e una patriottica convenzione fra tutte le classi sociali che non vivono parassitariamente di pubblici intrallazzi che la porti avanti.
PS. A livello storico, né il Partito Socialista Italiano né il Partito Comunista Italiano, né le grandi Confederazioni sindacali sono stati interpreti onesti e leali delle istanze dei lavoratori meridionali. Nel corso di un secolo e più, il tradimento si è rinnovato a ogni passaggio della vicenda nazionale. L’illusione è stata la regola. Liberarsi da tale ciarpame politico, per i meridionali è un dovere morale.
L’Italia
è un’espressione geografica. Non è mai
esistita politicamente. Persino l’unità
linguistica e quella culturale erano e sono più illusioni
che fatti. L’unità statuale si è
risolta in una mortificante forma di colonialismo interno.
La parola Italiani
è un’invenzione recentissima, se vista nel grande
arco della storia. Una parola che si è diffusa solo dopo la
conquista sabauda. Esisteva l’Italia, corrispondente alla
parte appenninica della penisola, però meno Roma e gli
Etruschi. Ed esistevano gli Italici. Ai confini d’Italia
c’erano i Galli padani. La parola Italiani, estesa anche ai
milanesi, rappresenta un’usurpazione, un falso storico.
|
Per comunicare con Nicola Zitara potete inviare un messaggio breve anche senza dover indicare il vostro indirizzo di posta elettronica: Se volete inviare una email
a Nicola Zitara: Nicola zitara - [email protected] Se, invece, volete comunicare con Zitara usando il nostro indirizzo, usate quello scritto sulla immagine sottostante. Ci dispiace ma l'indirizzo ve lo dovete scrivere da soli non possiamo metterlo in formato testo per evitare che venga catturato da chi si dedica allo spamming o ad altro. 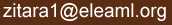 Buona navigazione e tornate a trovarci. |
Ai
sensi della legge n.62
del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del
materiale e
del web@master.