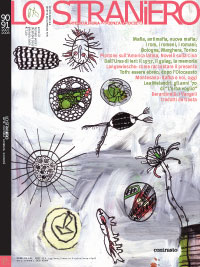Ringraziamo il Direttore Goffredo Fofi e la Redazione de "Lo Straniero" per averci autortizzato a riprodurre i seguenti articoli:
Chi è interessato a leggere altri articoli può collegarsi al sito della rivista “Lo straniero” e cercare nell'archivio. Buona lettura! |
Fonte:
https://www.lostraniero.net/ - Numero 90/91 - dicembre 2007/gennaio 2008
Mafia, antimafia, nuove mafie
di Alessandro Leogrande
Il cambiamento è ampiamente noto e, per fortuna, acquisito anche da un pubblico sempre più vasto. Ciò che è meno noto è che insieme alla mafia sta cambiando l’antimafia. E per antimafia si intende non il movimentismo di una parte della società civile (oggi in affanno e a corto di idee), ma le strutture speciali create negli ultimi vent’anni: Commissione parlamentare antimafia (in politica), Direzione investigativa antimafia (in polizia) e, soprattutto, le Direzioni distrettuali antimafia coordinate dalla Direzione nazionale antimafia (in magistratura). Ed è proprio il lavoro delle Dda – la prima vera linea del fronte – a essere mutato, pur nel silenzio generale, più drasticamente. Di cosa si occupano oggi i magistrati antimafia venuti dopo i loro fratelli maggiori che hanno istituito i grandi processi degli anni novanta?
Si potrebbe dire che il “processo Andreotti” è stato l’ultimo atto della Prima Repubblica, quando il rapporto tra mafia e partiti politici e lo scontro con la magistratura aveva luogo ancora secondo altre regole. Oggi lo Stato è debole, i partiti non ci sono più, la magistratura si è lasciata alle spalle Mani pulite e quando fa notizia è perché mette sotto inchiesta Lele Mora e Fabrizio Corona. Il vero potere è nelle banche e i capi cosca sono più simili agli agenti di borsa che ai vecchi mediatori del potere, così la magistratura è costretta a inserirsi in una lotta diversa – economica, non politica – più difficile da afferrare che in passato, perché sovente deterritorializzata. Faccio un esempio: anche dal punto di vista procedurale, stare dietro ai capitali rinvestiti ai quattro angoli del pianeta è molto più difficile che indagare sul voto di scambio all’interno della propria provincia.
Le Dda italiane non sempre hanno colto la necessità di una vera e propria frattura epistemologica, per stare al passo con il vasto mondo, ma quando una tale frattura è stata operata ha prodotto i suoi risultati. Ci sono oggi in Italia bravi magistrati e bravi carabinieri che hanno lavorato in questa direzione. Sono pochi, sono un’esigua minoranza rispetto alla maggioranza, ma ci sono – e con il loro operare hanno evitato il tracollo preoccupante che allignava all’orizzonte.
Un nuovo mondo dunque è alle porte e le mafie più potenti, che traggono vantaggio dall’indebolimento degli Stati, sono tra i principali produttori di modernità al pari delle grandi multinazionali. Ma c’è anche un’altra mutazione, a valle, da cogliere: la presenza delle cosiddette “mafie straniere” che vanno ad affiancarsi alle tradizionali “mafie italiane”. Sì, perché quando si parla di nuove mafie non ci si riferisce solo al fatto che Cosa nostra in Sicilia, Cosa nuova in Calabria e i “sistemi” campani sono aggregati criminali rinnovati e innovativi che controllano società finanziarie e il ciclo dei rifiuti. Ci si riferisce anche al fatto che oggi in Italia ci sono una mafia albanese, una mafia russa, una mafia cinese, una mafia nigeriana e – anche se in misura minore – una mafia romena.
Se si prendono in mano i rapporti periodici della Dia, ci si accorge che – ogni anno – subito dopo i primi corposi capitoli dedicati a Sicilia, Calabria, Campania e Puglia aumentano costantemente i numeri delle pagine dedicate alla “mafie straniere”. E poiché quei rapporti riportano dettagliatamente le indagini in corso e i procedimenti penali avviati, quell’aumento del numero di pagine è direttamente proporzionale all’aumento della loro attività sul territorio italiano. O, per essere più precisi, al miglioramento delle conoscenze investigative sul loro operare.
In che senso questi aggregati criminali costituiti da cittadini stranieri possono essere definiti mafie? Anni fa, parlando con un pm antimafia della Dda di Bari, mi disse che alcuni cartelli di Durazzo e Valona, che avevano già accumulato un notevole capitale controllando gli scafi dei migranti lungo il Canale d’Otranto, si stavano introducendo in Italia “controllando le strade”. Voleva dire cioè che la nuova mafia albanese – più affamata di quella italiana – stava assumendo (anche a colpi di kalashnikov) il controllo dello spaccio al minuto e dei viali della prostituzione in buona parte dell’Italia centro-settentrionale. Facendo il lavoro sporco che gli italiani non volevano fare più – la mutazione antropologica riguarda anche le attività criminali – stavano gettando le loro basi, costruendo le proprie roccaforti, e avrebbero presto rovesciato a proprio vantaggio il rapporto con i vecchi gruppi italiani. Questo è un dettaglio importantissimo per capire le relazioni criminali: le mafie continuano a essere forti se mantengono il controllo del territorio. Come sanno bene in Sicilia e in Campania, l’entrare in borsa non può disgiungersi dal mantenimento di quel rozzo e asfissiante potere. Se indebolisci le fondamenta – e le fondamenta sono anche i lavori sporchi del basso crimine – prima o poi il castello dei miliardi accumulati cadrà.
Dove però uno spazio da occupare è stato lasciato libero, nuove gang non-italiane si sono insediate. A volte sono su base etnica, altre volte creano mescolamenti transnazionali. Quasi sempre, più che di mafie vere e proprie (fondate cioè sul rito di affiliazione e sul radicamento storico in un luogo) si tratta di network informali, non pienamente strutturati, che vorrebbero farsi mafia. La loro forza non è nel controllo tradizionale del territorio, bensì nell’abitare gli anfratti dell’economia globale, nel saper saltare – quando occorre – i ponti tra gli Stati-nazione, offrendo “servizi” che nessun altro potrebbe offrire.
Se diamo un’occhiata ad alcune indagini degli ultimi anni, ci accorgiamo che il principale “servizio” che tali mafie svolgono è nel campo delle nuove schiavitù. Così ci si potrebbe accorgere che nel maggio del 1999 il Tribunale di Firenze ha condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso quattordici cinesi che tenevano letteralmente sottochiave alcuni loro connazionali, facendoli lavorare sedici ore al giorno nei laboratori tessili perché pagassero da sé il loro riscatto. Ci si potrebbe accorgere che nelle Dda di Ancora e di Trieste (le Dda non sono solo al Sud) ci sono importantissime inchieste sulla tratta di donne dall’Europa dell’Est o addirittura sul traffico di organi gestito da “i russi”. Ci si potrebbe accorgere che la procura antimafia di Bari ha appena aperto un processo contro caporali polacchi che avevano ridotto in schiavitù migliaia di loro connazionali affinché lavorassero nella raccolta del pomodoro per meno di dieci euro al giorno: a dare il via all’inchiesta, nella fattispecie, sono state le denunce di alcuni braccianti riusciti a scappare da uno dei “campi di lavoro” e le deposizioni del primo caporale straniero nella storia d’Italia che ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Ci si potrebbe accorgere che nell’area domiziana non è la camorra a gestire la prostituzione, bensì alcuni clan nigeriani che – strutturati al loro interno in modalità paramafiose – tengono in schiavitù centinaia di donne e, traendone enormi profitti, danno poi una percentuale ai clan della provincia di Caserta per ogni piazzola in cui si batte. (Detto per inciso, non c’è traccia da nessuna parte di un’organizzazione dedita al racket dei lavavetri...)
Gli esempi potrebbero continuare. Ma quanto citato basta per capire che il post-moderno non trionfa nelle regioni o nei settori in cui le mafie italiane “tengono meglio”, ma là dove – aprendosi campi liberi – si dipanano meglio gli spiriti animali del capitalismo criminale.
E qui bisogna essere precisi, per evitare di creare fraintendimenti. Solo una minima parte degli stranieri può dirsi fatta di criminali che magari sfruttano loro stessi connazionali (dico criminali: non disadattati, o “clandestini”). Solo una minima parte dei criminali stranieri è riconducibile al modello dei “nuovi mafiosi”. E solo una piccola parte delle nuove mafie è su base rigorosamente etnica, perché – il più delle volte – il denaro facile è il più potente aggregante di differenze che ci sia.
Come si combattono le nuove mafie? Innanzitutto tenendo ferme le differenze appena citate. In secondo luogo capendo che non servono leggi speciali, che il codice penale di cui disponiamo – se applicato – è pienamente sufficiente: l’unico provvedimento da introdurre al più presto riguarda pene più severe contro il caporalato in agricoltura e in edilizia. In terzo luogo, facendo propria la convinzione che occorre studiare molto, che l’investigazione è importantissima e che quindi bisogna apprendere le lingue, i gerghi, i nuovi riti e, soprattutto, i cambiamenti geopolitici, le guerre, le faglie socio-economiche che si ripercuotono sulle frontiere dell’Unione europea. In quarto luogo, bisogna tenere a mente che non esistono più “tempi lunghi”, che i cambiamenti sono spesso repentini. Faccio un altro esempio, sempre a proposito dei caporali in agricoltura nel Tavoliere: non si è fatto in tempo a capire che i caporali polacchi si erano sostituiti a quelli magrebini (che a loro volta si erano sostituiti agli italiani) che – arrestati i polacchi, o almeno buona parte di essi – i romeni e i bulgari ne hanno preso il posto.
Il fatturato delle nuove mafie è pochissima cosa in confronto alle ricchezze della camorra o della ’ndrangheta. La loro storia organizzativa è scarsa, recentissima, prima di una propria mitologia. Ma come tutte le organizzazioni criminali giovanissime fanno un uso della violenza spesso efferato. E soprattutto, ripeto, hanno il monopolio (garantito loro in subappalto dalle vecchie mafie italiane) delle attività, dalla prostituzione al lavoro, riconducibili alla riduzione in schiavitù: il reato del XXI secolo, in un mondo i cui attriti stanno per esplodere, e nel quale la dignità umana viene meno là dove c’è da garantire il mantenimento degli stessi margini di profitto.
I nuovi schiavisti non sono barbari imbarcati dal Sud del Mondo o dall’Europa povera. Sono aguzzini funzionali alla nostra economia, ed è questo il velo che andrebbe squarciato per smontare ogni stigmatizzazione etnica. Concentrati sul nostro recente passato e assillati dalle nostre mafie (che, potentissime, rimangono un modello da seguire per i criminali di mezzo mondo) non ci siamo accorti di essere entrati nell’era del crimine globale.
Se la magistratura si è dimostrata in parte all’altezza delle nuove sfide, lo stesso non lo si può dire per la politica, anche per il centrosinistra al governo. I luoghi comuni tirati fuori nel corso del dibattito sul pacchetto sicurezza, l’attenzione spasmodica concessa a quei reati di “immediato allarme sociale”, il fare della terribile morte di Giovanna Reggiani a Tor di Quinto il cavallo di battaglia per una svolta securitaria e xenofoba contro i rom, cioè il settore più povero dell’immigrazione, che niente ha a che fare con la grande criminalità di cui finora abbiamo parlato, tradiscono un enorme ritardo culturale. Oltre che una buona dose di malafede.
A nessuno interessa fare della lotta al grande crimine il tema all’ordine del giorno, perché quel crimine – la riduzione in schiavitù delle prostitute o dei braccianti, il traffico di coca – serve come il pane alla vita di molti. Dispiace dirlo, ma è così. Qualora però si decidesse di riflettere seriamente sulle nuove mafie (e non sui disadattati o sui lavavetri) ci si accorgerebbe che le espulsioni non servono. Che sono una risposta medievale (buttare la mela marcia al di là delle mura) del tutto inefficace in un’economia globale (in cui proprio quelle mura sono state abbattute).
Non solo. Se un mafioso straniero viene arrestato, nessun magistrato – giustamente – sarà disposto a firmare per la sua espulsione, perché solo tenendolo in Italia (al pari dei mafiosi italiani che magari vengono fatti estradare dall’estero) lo si potrebbe processare. E questa non è solo una necessità giudiziaria: i processi sono la principale fonte di conoscenza di cui disponiamo; e i nuovi collaboratori di giustizia – quando ci sono – sono i soli in grado di decostruire le nuove frontiere dell’universo criminale dall’interno. Espellendo tutti (magari senza fare distinzioni tra boss e affiliati, irriducibili e soggetti pronti a collaborare, denunciati e denuncianti) si reciderebbe con un colpo di mannaia quella fonte di conoscenza. Ma questo – come detto – non accadrà mai, perché la magistratura e le forze di polizia sono gelose del loro operato.
Contro chi si rivolge allora lo spauracchio delle espulsioni? Non verso chi delinque, ma verso chi “potrebbe” delinquere perché indigente, anche se proviene da un altro paese dell’Ue. Cioè contro i poveri cristi che se hanno qualche rapporto con il grande crimine è perché lo subiscono nel più feroce dei modi. Sollecitato dalle destre, oltre a dichiarare “guerra alla povertà straniera”, il governo di centrosinistra rischia di mandare al macero decenni di garanzie giuridiche, di evocare una “strategia delle manette” deterritorializzata e fondata su base etnica, del tutto inutile alla vera lotta contro le associazioni neomafiose. Sì, siamo proprio lontani dagli ultimi anni di vita di Falcone e Borsellino. E lontanissimi da quelli in cui Sciascia avviò la polemica (che oggi appare preistorica) sui “professionisti dell’antimafia”. Fosse vivo, il grande scrittore siciliano alzerebbe le spalle e scuoterebbe la testa. E riconoscerebbe forse di aver accusato, allora, gente molto più seria di quella che è oggi al governo – che poteva sbagliare sulla strategia da seguire, o trarne giovamento per la propria carriera, ma che non avrebbe mai preso lucciole per lanterne, non comprendendo dove vanno le nuove mafie, italiane e straniere.
Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del
Webm@ster.